 www.corsiadeiservi.it
www.corsiadeiservi.it www.corsiadeiservi.it
www.corsiadeiservi.itMorte cerebrale ed etica dei trapianti d'organo
Home / Archivio articoli ex sezione attualità / Archivio anni 2011/2012/2013 / Morte cerebrale ed etica dei trapianti d'organo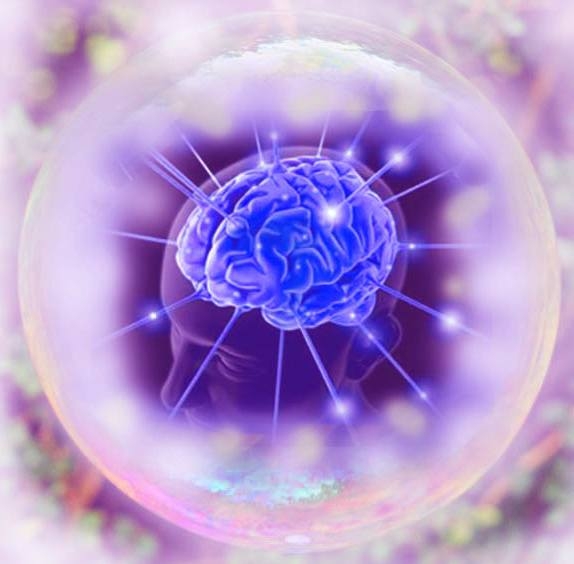 Il 3 Dicembre 1967, al Groote Schuur Hospital di Città del Capo, un quarantacinquenne cardiochirurgo sudafricano, Christiaan Neethling Barnard, sorprese la comunità scientifica mondiale realizzando il primo omotrapianto cardiaco: il cuore di Denise Darvall, una giovane donna vittima di un incidente stradale, venne trapiantato in un cardiopatico diabetico di nome Louis Washkansky.
Il 3 Dicembre 1967, al Groote Schuur Hospital di Città del Capo, un quarantacinquenne cardiochirurgo sudafricano, Christiaan Neethling Barnard, sorprese la comunità scientifica mondiale realizzando il primo omotrapianto cardiaco: il cuore di Denise Darvall, una giovane donna vittima di un incidente stradale, venne trapiantato in un cardiopatico diabetico di nome Louis Washkansky.
In realtà alla fine degli anni 60 molti chirurghi d’eccellenza, specialmemente statunitensi, dopo anni di sperimetazioni su animali, erano perfettamente in grado di eseguire trapianti cardiaci sull’uomo; ciò che li bloccava erano problemi etici e soprattutto legali: la certificazione di morte poggiava sul tradizionale criterio di arresto irreversibile cardiocircolatorio: non si poteva togliere un cuore battente ad un donatore senza incorrere nel reato di omicidio volontario.
Barnard riuscì a giocare d’anticipo, forse favorito da una minor sensibilità nazionale al problema. Il suo intervento venne accolto molto favorevolmente dal governo sudafricano, impegnato nel tentativo di recuperare visibilità internazionale dopo l’ostracismo subito a causa della sua politica di apartheid.
Il risultato terapeutico in realtà non fu per niente buono: Louis Washkansky sopravvisse solo diciotto giorni, stroncato da broncopolmonite bilaterale. Ma il passo era fatto. Si aprì una nuova e sconcertante strada terapeutica: il cuore, l’organo nel quale il comune sentire identifica la sede delle affettività e della spiritualità, poteva essere trasferito da un individuo ad un altro e Barnard divenne una stella internazionale.
Il suo intervento resta, però, una pietra miliare nella storia della medicina anche per le conseguenze che inevitabilmente seguirono. Per non restare “arretrato” rispetto alla chirurgia sudafricana, il mondo scientifico aveva a disposizione due opzioni: condannare l’espianto del cuore battente come inammissibile sul piano morale e legale perché mortale per il donatore o cambiare la definizione di morte.
Si preferì scegliere la seconda opzione che non risolse contestualmente l’aspetto etico.
Infatti, già nel mese successivo, venne istituito alla Harvard Medical School un comitato ad hoc, al fine di ridefinire il concetto di coma irreversibile.
Il comitato terminò il proprio lavoro in meno di sei mesi con il risultato che venne sostituito il concetto di morte dell’individuo secondo i classici criteri di arresto irreversibile cardio-circolatorio con quello della morte di un organo: la morte cerebrale.
Il lavoro venne pubblicato in modo inconsuetamente rapido sul numero di Agosto dello stesso anno dalla prestigiosa rivista medica JAMA.
Gli autori dichiaravano nella pubblicazione che il cambiamento dei criteri di definizione di morte si rendevano necessari oltre che per evitare l’accanimento terapeutico , anche per risolvere problemi di approvvigionamento d’organi per trapianto da donatore con cuore battente. Testualmente si affermava: «Criteri obsoleti di definizione di morte possono portare a controversie nell’ottenere organi a fine di trapianto».
A questo punto, rotto il tabù, il concetto di morte cerebrale conquistò prontamente tutta la comunità scientifica internazionale creando, come ampiamente prevedibile, una serie di problemi medico-scientifici, legati alla corretta diagnosi ed alla corretta previsione prognostica, oltre che legali, antropologici, filosofici, etici e religiosi.
Per stabilire se un individuo fosse morto, un tempo bastavano l’accertamento della protratta assenza di attività cardiaca e delle conseguenti alterazioni anatomiche: rigor mortis, chiazze ipostatiche, iniziali segni di putrefazione tissutale. Storicamente il medico era chiamato, in qualità di esperto, a certificare con atto ufficiale quello che il buon senso comune e l’esperienza della vita consideravano essere un cadavere; egli era, in altre parole, un ufficiale testimone, garante di un evento già avvenuto.
Con l’introduzione del concetto di morte cerebrale = morte totale, i medici cambiano di ruolo. Essi certificano qualche cosa di nuovo e di stupefacente: esistono dei cadaveri che hanno il cuore e la circolazione perfettamente funzionante, una efficiente funzione respiratoria, seppur supportata da apparecchiature, normali funzioni renali ed epatiche nonché digerenti; essi possono addirittura, se debitamente assistiti, portare a termine delle gravidanze.
Che i cadaveri possano mantenere tutte queste mirabili funzioni non è solamente contrario al buon senso, ma ontologicamente falso.
La comunità scientifica medica ha, di fatto, forzato la mano al legislatore, appropriandosi di un ruolo che non le compete: è passata dall’attestare l’avvenuta morte a stabilire il momento del trapasso, utilizzando tecnicismi esoterici, nel senso di difficilmente valutabili dai non addetti ai lavori.
La morte infatti, come abbiamo avuto modo di considerare nei precedenti numeri di questa rivista, è definita come il distacco dell’anima, spirito vitale, dal corpo. Questo momento non può essere identificato tramite strumenti scientifici; esso ha una dimensione trascendente, è un atto morale e come tale non imbrigliabile da metodi e diagnostiche strumentali, per quanto sofisticati essi siano.
La Chiesa Cattolica ha sempre tenuto in debita considerazione questa impossibilità di stabilire il preciso momento del trapasso. Basti ricordare un’ importantissima ricaduta nelle pratiche sacramentarie: l’Unzione degli Infermi e l’Assoluzione delle colpe, sacramenti riservati ai vivi, sono amministrabili «sub condicione» sino a due ore dopo la constatazione dell’arresto cardiocircolatorio.
Ogni organo non alimentato, seppur in tempi diversi, prima riduce e poi sospende la propria funzione; solo successivamente e non necessariamente in maniera contemporanea alla sospensione funzionale, si determinano profonde alterazioni anatomiche tali da rendere irreversibili la cessazione delle funzioni e la fine della vita.
Nel report di Harvard veniva proposto che lo stato di irreversibilità dovesse essere certificato utilizzando metodi puramente clinico – funzionali.
Dal punto di vista concettuale, ma anche pratico, non si può ritenere che la sola sospensione protratta di una funzione sia l’espressione della distruzione irreversibile di un organo.
In cardiologia ad esempio esiste una sindrome nota con il nome di «Tako Tsubo» (Il nome Tako Tsubo è un termine che indica uno strumento di pesca al polpo utilizzato in Giappone. Esso ha la forma di piccola anfora dal collo stretto e dalla base larga; questa forma è simile a quella che assume il cuore affetto da tale sindrome): un paziente che ha subìto un forte stress emotivo si presenta con forte dolore toracico, alterazioni dell’elettocardiogramma, come da infarto cardiaco acuto, ecocardiogramma e ventricolografia che dimostrano la totale assenza della funzione contrattile del muscolo cardiaco estesa a tutta la sua parte apicale ed esami del sangue come da sofferenza cardiaca. In altre parole, ci si trova di fronte ad un quadro che potrebbe essere definito come necrosi (morte) di una estesa parte del cuore.
Sorprendentemente, le coronarie (arterie che portano il nutrimento al cuore e che si chiudono quando si ha un infarto) in questi pazienti sono pervie. Ed ancora più sorprendentemente, la contrattilità cardica e la forma del cuore ritornano spontaneamente perfettamente nella norma, anche dopo diverse settimane dall’evento acuto.
L’imbarazzo della comunità scientifica cardiologica internazionale resta tutt’ora grande anche perché non se ne conosce ancora la causa.
Se tale reversibilità della funzione resta inspiegata nel cuore, organo sicuramente funzionalmente più semplice del cervello, sorge spontaneo il dubbio di come si possa accertare la irreversibilità funzionale del cervello, organo straordinariamente più complesso e per la maggior parte delle sue funzioni ancora misterioso.
Un altro fenomeno cardiologico che pone l’attenzione sulla non equivalenza tra protratta assenza di funzione contrattile cardiaca e morte cellulare (infarto) è il fenomeno dello «stordimento» miocardico e della «ibernazione».
In tali situazioni parti del cuore restano immobili come se fossero morte (alterata funzione), ma le cellule rimangono vitali e possono, con opportune terapie, essere riportate allo stato di normale funzionalità.
Nel cervello esistono analoghe alterazioni funzionali che non possono e non devono essere considerate espressione di danno irreversibile e che, se correttamente trattate, risultano reversibili.
Si tratta della cosiddetta «penombra ischemica» cerebrale, l’analogo neurologico della sindrome di «Tako Tsubo» o del miocardio stordito o ibernato.
Il definire «irreversibile» una funzione significa applicare una categoria di giudizio assoluta.
Il progresso scientifico e tecnologico nell’assistenza ai pazienti comatosi sposta continuamente il confine della “irreversibilità” funzionale, svuotando la definzione dalla sua presunzione assolutista.
Le diverse società scientifiche nazionali si sforzano, quindi, di cercare di identificare degli strumenti da proporre come sicuramente diagnostici di danno anatomico al quale corrisponda una irreversibilità della funzione.
Tali criteri, seppure applicati, sono stati sottoposti a continue modifiche, a testimonianza della loro solo temporanea adeguatezza (o presunta tale); essi sono oltrettutto differenti nei diversi Stati.
Un dichiarato morto cerebrale con criteri italiani non sarebbe “abbastanza” morto in un altro paese. Ciò imbarazza non poco: se non esiste un sistema comune per definire una morte, sorge spontaneo il dubbio della inadeguatezza di qualche certificazione.
La morte di un individuo, invece, deve essere considerata una verità oggettiva, certa, assoluta, da constatare con criteri univoci ed inequivocabili. Non è lecito utilizzare parametri di giudizio che si riferiscano «allo stato attuale delle conoscenze» e che normalmente il medico applica nelle diagnosi e alle cure delle malattie.
È stato da sempre così per ben più banali necessità di questioni ereditarie.
La teoria che supporta il concetto della «diagnosi di morte cerebrale = morte totale» poggia sull’ idea che il cervello sia dotato di una funzione coordinatrice globale dell’essere vivente; persa tale caratteristica, l’organismo è destinato ad evolvere in una sorta di caotica e letale dissincronizzazione funzionale.
Che tale concetto sia erroneo è stato dimostrato da studi osservazionali e da testimonianze di casi clinici sopravvissuti per anni, seppur assistiti, ai criteri diagnostici di «morte cerebrale».
Qualche sostenitore della pratica dei trapianti, pur ammettendo la vitalità del donatore, giustifica l’espianto d’organi a cuore battente affermando che ad un “essere” in tali condizioni non può essere riconosciuto lo “status” di persona e, quindi, perderebbe ogni diritto. Consueto appiglio ideologico già utilizzato in altri contenziosi bioetici (embrioni-aborti- eutanasia) che hanno lo stesso minimo comune denominatore, già ampiamente criticato in altri numeri di questa rivista.
È assolutamente inconfutabile quindi che il vero fine di queste certificazioni è quello di poter rendere disponibili organi vivi ed integri da trapiantare.
Un fine utilitaristico, quindi, che, nel momento in cui l’espianto di organi fosse effettuato da un individuo non morto, perderebbe di fatto la sua presunta valenza umanitaria.
Non si può allungare la vita ad un uomo malato o forse migliorarne la qualità sopprimendone un altro.
Tutto ciò sarebbe raccapricciante; evoca una sorta di primitiva e bestiale depredazione fatta a danno delle persone più indifese. Una specie di “rottamazione” dell’essere umano.
Vi sono inoltre altre questioni che devono essere considerate non solo sotto il profilo strettamente tecnico.
La domanda è: una vittima di incidente con trauma cerebrale che risulta essere candidato ad espianto d’organi è curato dall’inizio alla fine con il massimo delle risorse scientifiche a disposizione per cercarne il recupero o è semplicemente tenuto in osservazione in quanto raro candidato all’espianto?
La risposta ufficiale non può che essere una: è stato fatto tutto il possibile.
Ed allora facciamoci qualche ulteriore domanda di verifica:
Questi pazienti sono stati sottoposti ad ipotermia precoce, pratica che è in grado di favorire il recupero di funzioni in penombra ischemica o a terapie ormonali appropriate?
Come mai in alcuni stati, Italia compresa, viene applicato quale criterio di giudizio di morte cerebrale, il test dell’apnea (sospensione del supporto ventilatorio assistito per diversi minuti, stando a vedere se vi è spontanea ripresa della funzione respiratoria) che provoca un grave insulto cerebrale, potenzialmente in grado di distruggere un encefalo in penombra ischemica?
Come può un cadavere portare a termine, seppur assistito tecnicamente, una gravidanza?
Un paziente a cui è stata certificata la «morte cerebrale», ma che mantiene la ossigenazione corporea tramite assistenza ventilatoria meccanica e che, se venisse sospeso il supporto assistenziale ventilatorio, probabilmente, in un tempo più o meno breve andrebbe incontro ad arresto cardiaco irreversibile, non sarebbe meglio definibile come moribondo?
L’uomo è titolare di uno stato di diritti; la certificazione della morte è un atto medico che stabilisce il cessare di tale stato; esso deve solo certificare la non-vita. È lecito certificare una non-vita e, quindi, il cessare dell’insieme dei diritti suddetti tramite una certificazione, peraltro di discusso valore, dell’ irreversibilità funzionale di un organo?
Ammesso e non concesso che un paziente sia realmente in coma irreversibile, la morte cerebrale è veramente la morte dell’essere umano?
Dal punto di vista della legge, viene considerato donatore chiunque non abbia espresso intenzione di non esserlo; un consenso in tal caso “obbligatoriamente tacito”, visto lo stato di coma, che trovo ingiusto ed opportunista.
Molte persone che non hanno mai neppure preso in considerazione il problema vengono legalmente identificati come disponibili. È vero che prima dell’espianto viene fatto firmare un consenso informato ai parenti, spesso in condizioni di grave confusione emozionale. Ma con quale diritto un parente decide della vita di un congiunto e con che tipo di informazione? Il parente è morto o moribondo?
L’uso del termine «morte» riferito al cervello è chiaramente strumentale: evoca l’idea che quell’individuo è realmente morto. Il sostenere che «non c’è più niente da fare» e che il paziente è moribondo bloccherebbe di fatto la possibilità legale di espiantare gli organi.
La pratica degli espianti verrebbe vissuta con tutt’altra consapevolezza nella popolazione e negli operatori sanitari. I parenti probabilmente non si sentirebbero in grado, giustamente, di prendersi questa grande responsabilità. Se il paziente è moribondo non può essere espiantato. Si commetterebbe un omicidio.
È chiaro che l’ abolizione della pratica di espianto da individui dichiarati «cerebralmente morti» toglie una opzione terapeutica ad alcuni pazienti, oltre che notorietà ed immagine ad alcuni chirurghi. Ma non è lecito commettere un’ azione immorale neanche per un fine intenzionalmente buono.
Il togliere validità all’equivalenza morte cerebrale = morte totale, implica per gli «espiantatori» l’ automatica accusa di omicidio volontario e premeditato ed il coinvolgimento di una vasta ed eterogenea popolazione di collaboratori più o meno consapevoli, considerabili come complici.
Nell’ambito di questo numero cercheremo di fare il punto sulle problematiche introdotte dalla cosiddetta diagnosi di «morte cerebrale», finalizzata ai trapianti, analizzandole dal punto di vista scientifico, medico legale, filosofico ed alla luce del Magistero della Chiesa Cattolica.
Dott. Roberto Galbiati -Specialista in Cardiologia - Responsabile della Unità di Cura Intensiva Coronari Ospedale di Merate (Lc)
(Fonte: dalla rivista QUADERNI DI SAN RAFFAELE)
Documento stampato il 03/04/2025
